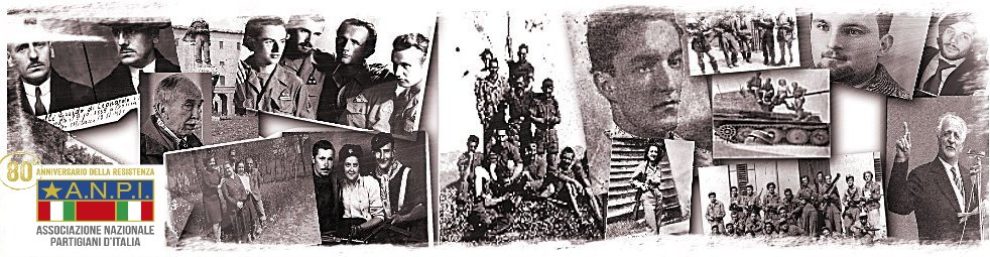Relazione introduttiva dei lavori
Nicola Maestri Presidente Comitato provinciale ANPI Parma
Buongiorno a voi tutte e tutti e benvenuti a questo Comitato Provinciale che avevamo annunciato all’assemblea dei CDS del 29 novembre scorso presso la sala della CGIL a Parma.
Il Vicepresidente vicario Stefano Cresci si è fatto carico di fare una sintesi di tutti gli interventi avvenuti in quella sede, oggi, come promesso, elaboreremo insieme quelle richieste nate da esperienze territoriali e uscite da quella giornata così significativa.
Proposta di progetto organizzativo
Comitato Provinciale
Dal tenore della discussione e dei singoli interventi nasce una richiesta di discussione ed elaborazione politica nonché di una maggiore incisività [...]
[...]
e una presenza sul territorio con l’esigenza di essere più organizzati e reattivi nelle risposte. In questi ultimi anni, grazie un buon lavoro fatto sul lato della comunicazione, tema sempre delicato ma cruciale se utilizzato in maniera intelligente, abbiamo offerto diverse possibilità di fruizione dal punto di vista informatico, anche se a mio avviso abbiamo ampi margini di coinvolgimento e miglioramento. Come saprete già tra un anno, di questi giorni, saremo immersi nella fase congressuale, per cui ritengo essere prioritario da parte nostra, guardare avanti e possibilmente interpretare correttamente quelle che dovranno essere le linee guida che ci permetteranno di dare un futuro solido alla nostra Associazione. Di semplice oggi c’è rimasto davvero poco. Einstein ha sempre parlato della necessità di non smettere mai di interrogarsi, sottolineando il valore della sacra curiosità, egli utilizzava spesso termini come passione, curiosità e fatica, noi aggiungeremo l’impegno, la conoscenza, la dedizione e l’ascolto e sono convinto che con queste premesse potremo trovare ancora molte cittadine e cittadini che si riconosceranno in questa tavola valoriale e pronti a camminare al nostro fianco. Il documento che Stefano ci proporrà è ovviamente una proposta e un progetto organizzativo che va nella direzione di una più efficace collaborazione tra i vari soggetti. L’ambizione è sicuramente quella di migliorare l’aspetto organizzativo ma al tempo stesso anche quella di avere una più forte spinta propulsiva e una più influente penetrazione culturale. L’obiettivo tangibile sarà proprio quello di implementare le attività e aggiungere volontari attivi su tutto il territorio provinciale che siano disponibili a un impegno più puntuale all’interno dei diversi ambiti del Comitato Provinciale. Devo correggere al rialzo il numero degli iscritti nel 2025. Infatti al termine dei conteggi gli iscritti ad ANPI del Comitato Provinciale sono poco più di 3350, credo sia un ottimo risultato che tutti insieme abbiamo contribuito a raggiungere. Le persone vedono nella nostra Associazione un baluardo democratico, tocca a noi, come recita il lascito morale di Giordano Cavestro e Giacomo Ulivi, dover prendere in mano il futuro. La fiducia c’è, è tangibile, alcuni passi di riqualificazione dei canali di informazione sono stati fatti, a questi dovranno seguirne altri e la proposta di oggi segue quell’orizzonte. Se ognuno di noi si farà carico di un piccolo peso da portarsi appresso ogni giorno, pensate un po’ quanti portatori di coscienza avremo, sollevando quei pochi che quel peso se lo accollano quotidianamente. Al tempo stesso aumenteremo la condivisione del messaggio che vogliamo veicolare.
Formazione e mobilitazione
per il Referendum
Per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, come sapete ANPI è tra i promotori a livello nazionale del Comitato per il No. Anche a Parma si è costituito tale Comitato formato da associazioni, partiti, sindacato, la cosiddetta società civile e lo scorso 17 gennaio abbiamo dato vita a un’affollata conferenza stampa. [...]
[...]
Abbiamo avuto già un incontro molto partecipato anche se in remoto con l’ex magistrato Domenico Gallo che ha avuto il pregio di esemplificare in maniera molto comprensibile temi da addetti ai lavori. Nei prossimi giorni, come Comitato per il NO, avremo diversi incontri, il 9 febbraio con la vice presidente del Senato del PD Anna Rossomando, il 18 di febbraio con il sindacalista della CGIL nazionale Christian Ferrari, in data da definirsi con la ex parlamentare M5S Giulia Sarti, mentre il 27
febbraio in un primo incontro di cartello con il Prof Francesco Pallante docente di Diritto Costituzionale all’Università di Torino e il Presidente del collegio giudicante del processo Aemilia e già presidente dei tribunali di Reggio Emilia e Bologna Francesco Maria Caruso. Il giorno successivo alle 16.30, organizzato dal circolo il Borgo si terrà a Parma un confronto pubblico tra chi rappresenta il SÍ come l’ex senatore Giorgio Pagliari e chi rappresenta il NO ovvero l’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo. Altri incontri sono in fase di definizione. Per marzo, con data da definirsi abbiamo in programma di organizzare un incontro con il Comitato “Giusto dire NO” dell’ANM Dott Ludovico Valotti, giovane magistrato con incarico a Parma, che abbiamo conosciuto alle celebrazioni per l’ottantanovesimo anniversario della morte di Guido Picelli, ci ha garantito la sua disponibilità per un incontro pubblico. Successivamente vi informeremo dei vari banchetti che si terranno a Parma in diversi punti della città. PD, M5S, Europa Verde hanno messo a disposizione del Comitato per il NO i loro banchetti già prenotati. Ci sarà bisogno anche dei nostri volontari per garantire una presenza assidua ai volantinaggi, soprattutto nelle ore di maggior passaggio, tipo il sabato pomeriggio ad esempio. Ci sembra però opportuno che anche la nostra Associazione faccia la propria parte verso i nostri dirigenti e iscritti. E dopo aver avuto la disponibilità da parte del responsabile di ANPI nazionale della formazione, nonché membro della segreteria provinciale Paolo Papotti, abbiamo deciso di fare un incontro specifico e mirato rivolto al nostro interno, in cui si tratteranno soprattutto gli aspetti che più riguardano i cittadini. Ci sembra giusto farlo per fornire maggiori strumenti da potersi spendere nei vari incontri che ci vedranno impegnati da qui al 22-23 marzo prossimi.
Manderemo a breve l’invito rivolto a tutti i comitati di sezione, vi anticipo comunque che il giorno stabilito sarà venerdì 13 febbraio alle ore 20.45, grazie all’ospitalità di CGIL il luogo sarà la sala Trentin in via Confalonieri a Parma.
Il referendum sul disegno di legge costituzionale cosiddetto Nordio, di fatto non riguarda la giustizia nel suo insieme, ma è una riforma rivolta solo alla magistratura.
La vittoria del SI avrebbe effetti dirompenti sull’intera giustizia, non solo penale ma anche civile, e il referendum riguarda quindi i diritti di tutti i cittadini, che non dovrebbero fare l’errore di sottovalutarlo, pensando che non si raggiungerà il quorum, perché in questo caso non occorre alcun quorum (si vince con un voto in più, a prescindere dal numero dei votanti).
Anche perché il referendum non coinvolge solo la giustizia, ma la democrazia nel suo complesso, che rischia di essere notevolmente indebolita se vincessero i SI.
Nel disegno di legge costituzionale non c’è infatti una riforma della giustizia diretta a rendere i processi più veloci, a rendere più facile l’accesso alla giustizia, a tutelare meglio i diritti dei cittadini. Nessun intervento sul numero dei magistrati, del personale, dei locali, delle strutture, dell’organizzazione degli uffici giudiziari, rivolto a migliorare tempi, efficienza e qualità dei procedimenti, no, non c’è traccia di tutto questo. Anche ascoltando gli attori di questa “deforma” si evince candidamente la volontà, nel medio e lungo termine, di voler assoggettare il potere giudiziario a quello esecutivo. La separazione delle carriere non c’entra assolutamente nulla, nonostante l’informazione stia martellando con affermazioni spesso menzoniere. Dalla riforma Cartabia del 2022 la separazione delle carriere è già nei fatti, tant’è che negli ultimi 5 anni una parte assolutamente marginale lo (0,31%) degli interessati cambia ruolo da giudice a pubblico ministero e viceversa, per cui cosa si nasconde dietro a questo disegno se non la malcelata volontà di un forte condizionamento della politica sulla magistratura? Oppure, leggendo in chiaroscuro il nostro percorso storico, si sta mettendo in pratica il progetto finale del maestro venerabile della Loggia massonica P2, Licio Gelli, i cui estimatori non mancano nell’attuale compagine governativa. Aldilà delle diverse letture e interpretazioni che ognuno di noi potrà individuare, ritengo sia giusto che la nostra Associazione si faccia interprete di questo impegno a difesa dell’impianto Costituzionale, perché è piuttosto evidente e grave l’attacco che si vuole portare al cuore delle nostre istituzioni. Non è la prima volta che questo avviene, ma probabilmente mai come ora è così fondato, reale e pericoloso, perché nonostante la lezione di Antonio Gramsci, nella società in cui viviamo l’indifferenza dilaga e questo rende assai permeabile e vulnerabile ogni sistema democratico. Il quesito referendario di marzo rischia di essere uno spartiacque tra il prima e il dopo. ANPI continuerà ad essere vigile e presente, assieme a tutte le forze democratiche e antifasciste, dentro e fuori il parlamento.
Abbiamo visto tutti il tentativo di Casapound, con l’aiuto di un esponente leghista, di varcare la soglia della sala conferenze della Camera dei deputati per presentare una proposta di legge sulla remigrazione. Il messaggio è stato chiaro, sono lì davanti pronti per entrare, per certi versi mi ha ricordato l’aggressione, l’attentato a Capitol Hill di cinque anni fa, quando decine, centinaia di persone violarono la casa delle istituzioni americane, e ciò è potuto avvenire perché questi personaggi si sentivano assolutamente sostenuti e protetti da una parte ben precisa dei poteri forti.
Bene hanno fatto, per fortuna, le forze parlamentari di opposizione ad occupare fisicamente la sala delle conferenze, impedendo di fatto questa vergogna. Gli spazi democratici ci vengono sottratti pezzo dopo pezzo, e il più delle volte in maniera silente, senza bisogno di sbraitare. Noi siamo stati, siamo e saremo sempre da quella parte, a difesa delle istituzioni e della autonomia e indipendenza tra i diversi poteri dello Stato, ognuno con le proprie funzioni a solenne difesa della democrazia.
Senza la volontà di voler drammatizzare questo momento storico, anche perché più di così diventa difficile, ma sono dell’idea che la democrazia così per come l’abbiamo conosciuta fino ai nostri giorni, stia attraversando un periodo di grave crisi, ragion per cui questo è il momento di serrare i ranghi e al contempo di allargare quanto più possibile i nostri orizzonti.